Lotta alla FAME nel Mondo: qualche considerazione sulle strategie operative

Con riferimento alla lotta alla fame nel Mondo, problema annoso e ancora irrisolto, non è certo sorprendente leggere le posizioni di Nigrizia nell’articolo “Lo sviluppo che non giova all’Africa” (19-06-2017) o quelle di F. Gesualdi in “NASAN addio: Macron fa la scelta giusta” (Avvenire, 16-02-18, p. 3), entrambi contrari a talune forme di aiuto in Africa. Sono note le posizioni di molte ONG contro gli investimenti dei Paesi ricchi in quelli poveri, in quanto rivolti a fare dei poli di crescita agricola, ma spesso sotto l’egida di multinazionali o di Paesi neo-colonialisti.
Trattasi di critiche in qualche misura condivisibili, vero è che non da oggi ne scriviamo (Bertoni e coll., 2016), poiché investimenti di questo tipo sono inevitabilmente destinati a realizzare estese piantagioni moderne e/o grandi complessi aziendali, allo scopo di produrre derrate facili da commercializzare, o sul mercato interno o per l’esportazione. Per quanto non siano per sé da demonizzare, poiché – se ben gestiti – questi investimenti possono accrescere sensibilmente le disponibilità alimentari del Paese beneficiario senza aggravare l’impatto ambientale, è indubbio che difficilmente portano alla riduzione dei problemi di sicurezza alimentare delle popolazioni povere locali, anche perché tendono a marginalizzarle ulteriormente. Tuttavia, viene da chiedersi: se negli ultimi 10 anni, come asserito da Nigrizia, l‘insicurezza alimentare si è aggravata a causa dei poli di crescita agricola (fortemente sostenuti, invece, dalla Banca Mondiale e dalla Banca Africana dello sviluppo), perché le così numerose ONG operanti in Africa da molto più di 10 anni non sono riuscite a conseguire miglioramenti sostanziali per le popolazioni rurali di questi Paesi (cioè la loro sovranità alimentare), grazie a strumenti ritenuti più efficaci e che, secondo F. Gesualdi, sono l’autoproduzione delle sementi e l’agricoltura biologica?
Fuor di polemica e lungi dall’idea di ritorcere sulle ONG le giuste critiche rivolte a talune forme di investimento nei Paesi poveri, il nostro obiettivo è far comprendere che non vi sono modi facili e scontati per risolvere i problemi agricoli dei PVS, specie se continuerà l’attuale tendenza ad operare per compartimenti stagni: da un lato i grandi investitori istituzionali e dall’altro i missionari e le ONG (rigorosamente in ordine sparso), mentre le autorità locali stanno semplicemente a guardare, quando non pretendano di partecipare alla festa…
Come è facile constatare, le ragioni di queste difficoltà operative sono numerose, ma noi crediamo che la principale sia – per chiunque e in ogni caso – il superamento dell’ultimo miglio, ovvero la distanza che separa i milioni di piccoli contadini dall’innovazione tecnologica, che riteniamo indispensabile al loro sviluppo, d’accordo con la FAO (FAO, 2014). Anche la nostra esperienza nei PVS mostra infatti che:
- gli interventi infrastrutturali e strutturali sono indubbiamente necessari, ma non sufficienti; ancora nei giorni scorsi abbiamo constatato (in Congo RD e in Etiopia) che la realizzazione di buone strade, anche nazionali, favorisce i commerci e ciò è un bene, ma i piccoli farmers (cioè la maggioranza della popolazione!), se lasciati soli in vista di un presunto autosviluppo, non sono in grado di avvalersene e anche altre componenti della società lo fanno in misura limitata per l’assenza di altri necessari fattori dello sviluppo;
- gli interventi di minor portata (in genere operati dalle ONG, dalle istituzioni religiose, ecc. e rivolti alla sanità, all’educazione, al miglioramento delle disponibilità di acqua potabile e a tanto altro) sono ugualmente necessari, ma troppo spesso si limitano a forme di tipo assistenziale e/o emergenziale;
- in entrambi i suddetti casi, i governi dei PVS e le loro amministrazioni sono poco coinvolti e in generale anche le popolazioni lo sono in maniera passiva.
Non può quindi meravigliare se gran parte degli interventi, anche nelle forme più disinteressate ed oneste, hanno avuto ed hanno modeste probabilità di successo in numerosi Paesi poveri. A nostro parere, si conferma che il denominatore comune di tutti questi insuccessi – anche se non l’unico – è proprio l’incapacità di colmare la distanza che separa i piccoli contadini dagli Enti che di essi vorrebbero occuparsi: il predetto ultimo miglio. Semmai aggiungiamo che detta incapacità non discende solo da una certa inadeguatezza di chi intende portare l’aiuto, ma è soprattutto frutto di alcuni aspetti culturali delle popolazioni povere – forse originata dalla frustrazione, oltre che dall’insufficiente formazione scolastica – che le porta alla passività più disarmante.
Nonostante ciò, il quesito non è se si debba continuare con interventi di grande dimensione o con quelli piccoli, ma numerosi delle ONG, entrambi sono comunque necessari. Invece, ci si deve interrogare – oltre che sulle reali finalità di chi opera questi interventi – sui modi più adatti ad ovviare ai predetti ostacoli culturali che si frappongono allo sviluppo. Per rispondere a questi interrogativi è anzitutto necessario considerare quanto segue:
- nel caso di interventi di tipo istituzionale, quindi concordati con i governi locali, la logica vorrebbe che le popolazioni siano intensamente coinvolte per il tramite delle istituzioni scolastiche, sanitarie e amministrative; purtroppo, la capacità (e/o volontà) di far questo è insufficiente e lo stesso dicasi per la successiva gestione delle opere realizzate;
- l’immediata conseguenza è che i portatori degli aiuti dovrebbero preoccuparsi di tutti gli aspetti, compreso quello relativo all’ultimo miglio, ma spesso mancano della necessaria consapevolezza e comunque della capacità operativa;
- è ben noto che nei PVS la popolazione è “rurale” per il 70-80%, mentre il resto vive nelle città, in larga misura di espedienti. Il primo passo, pur senza escluderne altri, dovrebbe quindi essere quello di favorire lo sviluppo agricolo, per uscire dalla sussistenza, migliorare la disponibilità di cibo e generare un minimo reddito famigliare necessario per attivare forme commerciali-artigianali di ogni tipo. Interessante al riguardo quanto affermato dalla Banca mondiale: “Lo sviluppo agricolo è uno degli strumenti più potenti per porre fine alla povertà estrema, accrescere una diffusa prosperità e sfamare gli oltre 9 miliardi di persone nel 2050” (Banca Mondiale 2016a); aggiungendo poi: “Lo sviluppo nel settore agricolo è da 2 a 4 volte più efficace, rispetto ad altri settori, nel migliorare la situazione economica dei poveri” (Banca Mondiale 2016b);
- un corretto sviluppo rurale richiede un approccio olistico, come giustamente indicato da Vos e coll. (2017) in IFPRI blog del 16 Ottobre 2017; in particolare, ciò significa andare oltre l’azienda agricola per conseguire anche opportunità lavorative al di fuori dell’azienda e per integrare la popolazione rurale con il mercato, dal quale è oggi largamente estranea. È quanto da tempo sosteniamo, all’interno del nostro modello C3S (Bertoni, 2015): non vi può infatti essere vero sviluppo rurale se non si aprono vie alternative e complementari all’agricoltura famigliare, almeno per i giovani che, raggiunto un certo grado d’istruzione, non torneranno mai a zappare.
Ora chiediamoci: questa modalità d’azione è prevista e realizzabile nell’ambito degli interventi istituzionali, quelli che potremmo esemplificare con l’espressione oggi in voga di “aiutiamoli a casa loro”? Se analizziamo due proposte recenti, ne abbiamo seri dubbi. Per esempio, il prospettato Piano Marshall per l’Africa, (Viceministro Mario Giro, Avvenire del 7 luglio 2017, p. 3 in occasione della Conferenza Generale della FAO) o il programma d’azione promesso dal Presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani (Avvenire, 23 novembre 2017, p.14): meno aiuti e più investimenti, in grado di movimentare cifre private ben maggiori. In entrambi i casi si tratta, immaginiamo, della fornitura di strutture e/o infrastrutture di cui si è già detto in precedenza, ma che difficilmente andrebbero a incidere in un contesto povero di tutto, specie in mancanza del necessario coinvolgimento locale tanto raccomandato da Nzamujo (2010).
Per certi versi, la proposta dell’ex Ministro Tremonti appare in controtendenza, dato che – consapevole delle difficoltà strutturali appena ricordate – ha suggerito di by-passare i governanti di quei Paesi affidando l’operatività al volontariato (Avvenire, 2 luglio 2017, p. 7). Anche in questo caso, tuttavia, la proposta non è del tutto chiara, senza poi trascurare il fatto che parlare di volontariato, come garanzia di successo a prescindere, pare eccessivo. Gli interventi delle ONG, infatti, sono senza dubbio encomiabili, ma i risultati sul piano dello sviluppo rurale lasciano spesso molti dubbi. Una probabile causa dell’insuccesso risiede nella mancata copertura dell’ultimo miglio, quello che – come detto in precedenza – porta l’innovazione tecnologica fino al singolo contadino. Eppure, è noto che solo queste organizzazioni, insieme a quelle missionarie potrebbero garantire quest’ultimo passo, stante la capillarità della loro diffusione. Anche in questo caso si deve tuttavia ammettere che neppure il contatto con la popolazione, da solo, non basta ai fini di avviare lo sviluppo rurale di un Paese; specie se, come nello specifico, gli aiuti consistono in una miriade di piccoli, singoli progetti, frutto di motivazioni quantomeno variegate e spesso velleitarie, per lo più senza un vero e proprio substrato tecnico e soprattutto senza alcun tentativo di coordinamento fra i vari Enti e neppure all’interno della stessa entità confessionale. Non abbiamo sin qui parlato della FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations), l’istituzione nata nel 1945 proprio con il compito di porre rimedio al problema della fame nel mondo. In realtà, anch’essa ha conseguito risultati inferiori alle attese, almeno in quei Paesi ove le carenze del sistema economico e strutturale compromettono la capacità di applicare efficacemente le nuove tecnologie. Forse, anche in questo caso, a difettare è stato proprio il contatto con i contadini, che si è detto essere insostituibile.
Che fare dunque?
Se quindi nessuna delle organizzazioni o enti che si occupano di sviluppo nei PVS pare disporre in toto delle armi adeguate al conseguimento dell’obiettivo, si deve ammettere che la situazione è desolante: nessuna delle principali entità dalle quali ci si attende un contributo significativo alla soluzione dei problemi della fame nei PVS è nelle condizioni di mettere in campo tutti gli strumenti necessari. In particolare, nella poliennale esperienza personale, è emerso che:
- non basta far giungere informazioni tecniche, ancorché corrette e appropriate; le popolazioni locali hanno infatti bisogno di vederle applicate in dimostrazioni dirette, obbligatoriamente con la loro partecipazione (ricordiamo il proverbio africano: quello che tu fai per me, senza di me, è contro di me);
- è comunque indispensabile, affinché le tecniche suggerite possano essere efficacemente adottate, che siano resi disponibili, sulla porta della capanna, anche i mezzi tecnici necessari per la loro concreta realizzazione; ovviando quindi alla difficoltà di reperimento e all’ignoranza circa il loro utilizzo (pur trattandosi di cose necessariamente semplici e alla loro portata);
- le popolazioni rurali debbono, inoltre, essere portate per mano al superamento degli atavici atteggiamenti di sfiducia e di individualismo; ciò al fine di facilitare l’accettazione dei primi due punti e di convincerle sull’opportunità di interagire con il mercato (sia per acquisire i mezzi tecnici di produzione e sia per collocare i prodotti in qualche modo eccedentari rispetto alle esigenze famigliari);
- gli interventi di finanziamento esterno debbono poi essere programmati, sin dall’inizio e in modo esplicito, per avere un termine; termine che non significa troncare meccanicamente gli aiuti alla data di scadenza, quando magari il percorso intrapreso è ancora in mezzo al guado, ma semplicemente porsi l’obiettivo di conseguire la necessaria auto-sostenibilità in tempi accettabili, con la completa consapevolezza della popolazione beneficiaria.
Di tutto ciò, raramente si è tenuto conto nell’affrontare i problemi dello sviluppo nei PVS, neppure da parte dei missionari (religiosi o laici); questi paiono al contrario convinti che basti mostrare il nuovo (e magari su scala ampia e con tecnologie magnificenti) per stimolare la pronta emulazione da parte delle popolazioni locali. Di qui probabilmente i numerosi casi di insostenibilità dei progetti posti in essere, piccoli o grandi che siano, situazione che si manifesta non appena termini il supporto esterno. In verità, c’è da chiedersi come sia possibile immaginare un’emulazione, da parte delle famiglie contadine, quando si tratta di tecnologie che implicano investimenti consistenti, non solo per strutture e infrastrutture di interesse generale, ma anche per controllare l’acqua, per acquisire i mezzi tecnici richiesti dall’agricoltura intensiva (macchine, concimi, erbicidi, antiparassitari, sementi migliorate ecc.), nonché per conservare e commercializzare i più copiosi prodotti agricoli così ottenuti. Anche in questo caso, tuttavia, non siamo aprioristicamente contrari ai progetti di natura intensiva, benché si addicano a complessi aziendali di medio-grandi dimensioni. Infatti, se ben gestiti, oltre a garantire la sostenibilità economica e quella ambientale, potrebbero aumentare la produttività di quelle aree; il loro limite è semmai la sostenibilità etico-sociale, poiché peggiorano la condizione dei milioni di piccoli contadini che in essi non troverebbero grande spazio lavorativo, mentre verrebbero loro sottratte consistenti superfici, oltre a metterli in competizione, per gli sbocchi di mercato, con forze soverchianti. Pertanto, queste ultime, indipendentemente dal fatto che siano da attribuire ad interventi esterni (spesso definiti come land-grabbing) od a soggetti interni al Paese, non sono di per sé da demonizzare, soprattutto quando il loro obiettivo sia quello di soddisfare in tempi brevi la richiesta di elevate quantità di alimenti di altrettanto elevati standard igienico-qualitativi per il mercato locale o per l’esportazione. Al contrario, potrebbero divenire accettabili se, nel costituire i necessari poli di crescita agricola, lasciassero uno spazio vitale anche per le piccole aziende familiari (delle quali dovrebbero essere indotte ad accollarsi un qualche supporto tecnico-organizzativo).
Ipotesi di intervento nei PVS
Le nostre riserve non riguardano pertanto gli interventi in sé a favore dei PVS, quanto piuttosto i modi, non soltanto in termini tecnici, con cui vengono realizzati. Questi modi non sono infatti un aspetto secondario, poiché condizionano le scelte politiche degli aiuti, siano essi operati da Paesi cooperanti o da Enti caritativi, oltre che i loro esiti. In sintesi, ricordiamo che, per realizzare uno sviluppo rurale diffuso fra la popolazione:
- gli investimenti dall’esterno, atti a correggere le manchevolezze strutturali di questi Paesi (strade, mercati, scuole ecc.) o ad avviare attività imprenditoriali di qualsivoglia natura, non paiono sufficienti se vi è poca attenzione allo sviluppo rurale, dato che il 70% e oltre della popolazione è oggi dedita a un’agricoltura di sussistenza;
- è illusorio pensare che la semplice diffusione delle informazioni, comunque avvenga e qualunque sia l’agenzia che la promuove, possa garantire l’acquisizione dell’innovazione da parte di piccoli contadini che ancora praticano un’agricoltura tradizionale da tempi immemori;
- l’istruzione scolastica, ancorché necessaria per altri aspetti, potrebbe risultare poco efficace ad accendere e consolidare uno sviluppo rurale, almeno nel breve-medio periodo; la scolarizzazione, infatti, è il primo passo per l’allargamento delle aspirazioni personali verso altri stili di vita, comportando quindi il conseguente abbandono dell’agricoltura attuale, soprattutto da parte dei giovani che la ritengono del tutto insoddisfacente;
- è invece assolutamente necessario combattere, specie fra le generazioni adulte, quell’insieme di ignoranza, di ideologia con base superstiziosa e di frustrazione-pigrizia che pervade queste popolazioni. Quest’ultimo sentimento è per certi versi comprensibile, benché non giustificabile, a causa dei frequenti fallimenti seguiti ai loro tentativi di migliorare la produttività agricola e il loro tenore di vita. Questi fallimenti sono in buona parte imputabili all’incapacità di controllare i fattori avversi (incapacità insita in quei sistemi produttivi, ma che per i nostri occhi occidentali potrebbe essere superata con interventi da ritenere addirittura banali);
- le Agenzie incaricate di supportare lo sviluppo nei Paesi poveri (compresa l’Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo) non dovrebbero limitarsi ad investimenti strutturali e/o infrastrutturali, né a diffondere genericamente le conoscenze necessarie per l’innovazione. In particolare, per quest’ultimo aspetto occorre che a veicolare l’informazione-innovazione siano entità capillarmente diffuse anche nelle periferie (parrocchie, ONG laiche o religiose ecc.), ben inserite fra la popolazione e abili ad aiutare i contadini ad assimilarla. A loro volta, queste entità periferiche – che certamente già esistono – dovrebbero essere appositamente preparate e potenziate allo scopo di organizzare i contadini nel reperimento dei mezzi tecnici (sementi, fertilizzanti, piccole attrezzature, ecc.), nel farne un uso appropriato e, ove possibile, nel commercializzare i prodotti agricoli eccedentari;
- per essere più espliciti, ribadiamo il concetto che idonee sub-agenzie tecniche (governative e non), dovrebbero essere incaricate – dai responsabili dei progetti di sviluppo – del compito di interfacciarsi con le predette entità periferiche per fornire loro le linee guida (e il supporto finanziario) per attuare, nelle specifiche condizioni locali, gli auspicati poli di sviluppo rurale sostenibile, premessa di quello complessivo.
Ci si chiederà (giustamente) come mai queste procedure operative non possano essere attuate direttamente dalle amministrazioni dei Paesi coinvolti; purtroppo la realtà dimostra che se ciò fosse possibile, non saremmo qui a parlarne e non solo in campo agricolo, ma anche per l’istruzione e per i servizi sanitari (altri ambiti ampiamente deficitari nei PVS). Contemporaneamente, programmi esterni di sviluppo rurale basati sul predetto approccio olistico sono stati molto rari, quando non del tutto assenti. Crediamo pertanto utile proporre il nostro modello C3S (Bertoni, 2015) che ai predetti principi si è ispirato e che, essendo ancora in fase di parziale realizzazione, necessiterebbe di più ampia valutazione già a priori o, ancor meglio, a seguito di ulteriori tentativi di attuazione. La nostra esperienza col modello C3S è ora sessennale e, sia pure con risultati alterni, si è mostrata promettente in India (Meghalaya), nella Repubblica Democratica del Congo (Lomami) e in Etiopia (Gurage); in particolare si è dimostrata in grado di superare l’ultimo miglio e di attivare le forze sopite del mondo rurale. Ciò a conferma che, per il successo dei progetti di sviluppo rurale, serve anche un’azione diretta – sia pure a partire da una selezione dei contadini più sensibili e aperti all’innovazione – purché mediata da persone loro vicine (religiosi, operatori di ONG, ecc.) con le quali abbiano già una consuetudine di vita e ne parlino la lingua.
Conclusioni
Pur consapevoli che anche l’approccio sopra teorizzato possa non essere risolutivo, soprattutto a causa della disomogeneità degli interlocutori da noi indicati come potenzialmente in grado di svolgere la necessaria intermediazione (l’ultimo miglio); solo in questo modo, a nostro parere, risulterebbe possibile costituire nuclei locali di sviluppo rurale (non già poli) che, se basati su tecnologie appropriate, potrebbero facilmente creare i presupposti per una emulazione alla portata di gran parte dei piccoli contadini delle aree circostanti, proprio grazie alla cosiddetta diffusione passiva dell’innovazione. Questa è un’esigenza fondamentale, considerando che sarebbe pura utopia pensare di coinvolgere direttamente e singolarmente tutti i milioni di piccoli contadini di un Paese in via di sviluppo. In buona sostanza, il nostro auspicio è che si possa realizzare una collaborazione, sperabilmente confortata dall’adesione convinta delle Amministrazioni locali, affinché le tre entità di cui si è parlato sopra – FAO, Governi donatori e ONG/Istituzioni religiose – possano agire di concerto per introdurre i necessari miglioramenti, ma anche facendo in modo che l’innovazione tecnologica giunga fino in periferia, possibilmente in maniera e con contenuti univoci. Ovviamente, questi mediatori dovrebbero essere appositamente formati, oltre che sostenuti tecnicamente e finanziariamente (sia pure a livello istituzionale). Siamo ugualmente consapevoli che quanto sopra auspicato rischia di essere un desiderio irrealizzabile nel breve periodo, poiché punta sul coinvolgimento, e a livello elevato, di enti estremamente diversi. Ci chiediamo allora se non sia tempo che almeno le organizzazioni religiose e le ONG, convertano il loro modello di aiuti nei PVS (in genere fatto di progetti prettamente assistenziali, di piccole dimensioni e poco coordinati) per avvicinarlo a quanto da noi proposto: uno sviluppo dal basso, opportunamente guidato e avendo fra gli obiettivi principali l’auto-sostenibilità da tutti i punti di vista. Oltretutto, si creerebbero così le premesse per la successiva disponibilità a cooperare con la FAO e i grandi investitori, rendendo in tal modo più efficace l’azione di tutti. A maggior ragione, in quanto appartenenti ad un’Università Cattolica, il nostro auspicio è che sia la Chiesa Cattolica a farsi pioniera e quindi guida nella direzione ispirata dal nostro modello di sviluppo, anche per sollecitare l’adesione di altri. In tal modo, prendendo a prestito la metafora del tavolo, la Chiesa cattolica dovrebbe approntare la quarta gamba: lo sviluppo rurale – in aggiunta all’azione pastorale, all’intervento in campo sanitario e a quello educativo, le tre che già la contraddistinguono – nella prospettiva dello sviluppo integrale dei Paesi poveri. Ciò senza tuttavia dimenticare che l’obiettivo finale è a nostro avviso quello dell’integrazione delle strutture tecniche di tali Paesi (Università, Enti di ricerca, Enti di assistenza tecnica) – spesso insufficienti – con tecnici della FAO o provenienti da Paesi sviluppati, per attivare apposite task force che poi utilizzerebbero (prevalentemente come braccio operativo) le entità periferiche rappresentate da parrocchie, presìdi di ONG ecc.
Prof. Giuseppe Bertoni giuseppe.bertoni@unicatt.it
Prof. Vincenzo Tabaglio vincenzo.tabaglio@unicatt.it
Bibliografia
Banca Mondiale (2016a) Health, nutrition and population: http://datatopics.worldbank.org/hnp/popestimates
Banca Mondiale (2016b) Poverty and Shared prosperity report 2016: taking on inequality. Policty research working paper 7844. Available at:
http://documents.worldbank.org/curated/en/187011475416542282/pdf/WPS7844.pdfhttp://
documents.worldbank.org/curated/en/187011475416542282/pdf/WPS7844.pdf
Bertoni G. (a cura di), Tabaglio, V., Ganimede C., Trevisan M., Pellizzoni M., Anaclerio M., Cappa F., Grossi P., Fiorani M., Ndereyimana A., Minardi A., Sckokai P., Guastella G., Chiesa M., Rossi L. 2015. Produzione e uso del cibo. Sufficienza, sicurezza e sostenibilità. Ed. EGEA, Milano ISBN 978-88-238-5133-7
Bertoni G., Grossi P., Fiorani M., Ndereyimana A., Minardi A., Ganimede C., Tabaglio V. (2016) Innovation to overcome subsistence agriculture on family farms in developing countries: the role of the Chatolic Curch. Rivista internazionale di Scienze Sociali, n.2 pp 199-212
FAO (Food and Agriculture Organization), 2014. The State of Food and Agriculture: Innovation in Family Farming, Roma.
Nzamujo G. (2010) Songhaï, Quand l’Afrique relève la tête, Editions du CERF, Paris.


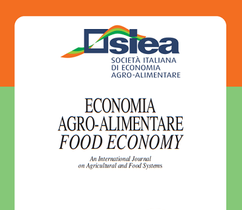





Grazie a Bertoni e Tanaglio per gli spunti di riflessione molto utili, che condivido in larga parte, soprattutto per quanto riguarda la necessità del coinvolgimento attivo delle popolazioni locali in genere e degli stakeholders delle filiere alimentari in particolare. Gli autori parlano di innovazione tecnologica. Credo che bisogna considerare anche l’innovazione organizzativa: seconda la ia esperienza in molte situazioni interventi su come prodotti agricoli vengono commercializzati, per esempio, possono essere più efficaci interventi sulla fase produttiva.