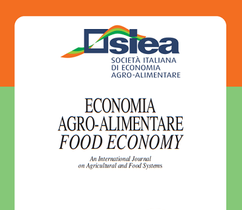L’altro modo di possedere la terra
Non esiste soltanto la distinzione tra proprietà pubblica e privata, c’è anche una terza via, che in realtà precede tutte le altre: la proprietà collettiva, ovvero un patrimonio che non appartiene né allo Stato, né alle Regioni, né agli enti locali anche se talvolta è imputato catastalmente ai comuni. Tali patrimoni possono essere sottratti alla gestione dei comuni. Un insigne giurista e storico del diritto, Paolo Grossi, ha fornito un’interpretazione della storia delle proprietà collettive da una prospettiva nuova e originale
Molti ritengono che le forme di proprietà siano soltanto due: pubblica e privata. Esiste, in realtà, da epoche remote un altro modo di possedere: la proprietà collettiva. E questa forma precede tutte le altre. Si tratta di un patrimonio fondiario che non appartiene né allo Stato, né alle Regioni, né agli enti locali anche se talvolta è imputato catastalmente ai comuni. Sono beni di proprietà delle collettività locali.
In origine l’intero territorio di Roma apparteneva a tutto il popolo. E per attribuire ai singoli patres familiarum una forma di appartenenza individuale lontanamente somigliante all’odierna proprietà privata fu necessaria una divisio del territorio comune effettuata mediante una lex regia. Bisognerà attendere la fine del II secolo a. C., quando la giurisprudenza, dopo una laboriosa e tormentata elaborazione dottrinale individua un dominium ex iure Quiritium, e cioè un potere pieno ed esclusivo del terreno assegnato. E solo allora si potrà distinguere, da un lato, la proprietà privata e, dall’altro, la proprietà collettiva.
Le forme di possesso comune delle risorse naturali sono state in Italia, così come in altre parti dell’Europa, in gran parte soppresse nel corso dell’ottocento da una legislazione volta, invece, ad affermare e generalizzare la proprietà privata. In tale periodo prevale la volontà di eliminare, “liquidare” i beni comuni in tutte le loro forme e manifestazioni, vedendole come delle anomalie rispetto all’ordine giuridico ed economico dato. Il Codice Civile del 1865 risente di questo clima ed evita accuratamente di contemplarle.
Ma già una nuova legislazione, a cavallo tra anni ottanta e novanta del XIX secolo, esprime la necessità di mantenere le forme di possesso comuni laddove per l’altitudine e la natura dei fondi, le terre non possono essere migliorate dal punto di vista agricolo. È il risultato di analisi attente di tali fenomeni effettuate nell’ambito delle grandi inchieste ministeriali sulle campagne italiane da studiosi come Stefano Jacini e Ghino Valenti. L’idea che prevale in tali studi è che la proprietà collettiva non nega il progresso, ma assicura invece forme associative di uso del territorio, essendo essa stessa una sorta di cooperazione. Sono forme d’uso volte a tutelare le comunità attraverso una serie di vincoli, di divieti all’uso di tecniche che possono ridurre la riproducibilità delle risorse, di norme volte a mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione e territorio. E tuttavia, benché tale filone di studi filosofici, storici, agronomici e giuridici sugli assetti agrari collettivi che si sono conservati nel tempo sia giunto fino a noi, la modernità contemporanea si è costruita sul trinomio proprietà-ricchezza-progresso. Secondo questo sistema di valori, il proprietario è per natura il cittadino modello perché nel rapporto coi suoi beni è inevitabilmente favorevole alla conservazione e all’ordine costituito. Al contrario, ogni ordine sociale e politico che si fonda sulla comunità e sulla proprietà collettiva rompe inevitabilmente questo nesso, e diviene qualcosa di mostruoso che non può essere accettato e deve essere negato.
Un insigne giurista e storico del diritto, Paolo Grossi, ha fornito un’interpretazione della storia delle proprietà collettive da una prospettiva nuova e originale: l’intervento diretto a sopprimere tali istituzioni non è l’esito di un processo volto a distruggere un sistema di valori arcaico per affermarne un altro teso a dispiegare forze sociali e politiche progressiste e modernizzatici; è, al contrario, il risultato di un percorso teso ad eliminare quell’armatura istituzionale propria delle common property che si ispira alla necessità di garantire a coloro che non possiedono nulla di poter vivere in modo dignitoso e di preservare, a tal fine, le risorse da forme di sfruttamento indiscriminato e devastante.
Lo studioso racconta una storia bandita dai libri di testo utilizzati nelle scuole; una storia in cui le comunità sono state capaci di coordinarsi, limitare la libertà individuale e così non collassare tragicamente. Norme sociali, ordinamenti, regole, tradizioni, usi e consuetudini sono gli strumenti del diritto che le comunità hanno inventato proprio per evitare di autodistruggersi.
Le proprietà collettive sono beni e diritti inalienabili, indivisibili, inusucapibili, imprescrittibili. Il loro uso non può essere per alcuna ragione modificato. Sono diritti reali di cui i residenti godono da tempi immemorabili e continueranno a godere per sempre ma in comune – cioè senza divisione per quote – per ritrarre dalla terra le utilità essenziali per la vita. A seconda dei territori in cui sono presenti, le proprietà collettive vengono variamente denominate: “associazioni degli antichi originari”, “cantoni”, “vicinìe”, “vicinanze”, “consorterie”, “consorzi”, “consortele”, “regole”, “interessenze”, “partecipanze”, “comunaglie”, “comunanze”, “università agrarie”. Nei territori dell’ex Regno di Napoli, nella Sicilia e nella Sardegna le terre di uso collettivo sono di proprietà comune della generalità dei cittadini del comune o delle frazioni che separatamente le amministrano e vengono denominate “demani comunali”. Gli enti che gestivano le terre collettive originariamente svolgevano non solo compiti di organizzazione degli spazi agricoli comuni per il soddisfacimento di bisogni primari, ma anche funzioni pubbliche, come pagare il medico e la levatrice oppure curare la manutenzione dei fiumi, delle strade e delle fontane. Non costituivano mai solo comunità di proprietà, ma sempre comunità di vita.
Le proprietà collettive che tuttora si sono conservate sono autonome e disciplinate da antichi Laudi e Statuti che codificano tradizioni ancora più antiche, nate dalla libera scelta dei titolari (ed aventi diritto al godimento) di tali beni di imporsi dei limiti nel loro godimento, al fine di perpetuarli alle generazioni future. Questo vincolo auto-imposto, che limita innanzitutto la piena disponibilità e fa del dominio dei legittimati una situazione tutt’altro che assoluta, pone la realtà delle proprietà collettive in una prospettiva irriducibile al rigido binomio tra proprietà privata e proprietà pubblica.
La proprietà collettiva si definisce, infatti, su tre elementi necessari: 1) la comunità, cioè una pluralità di persone fisiche legate fra loro da un vincolo agnatizio oppure individuata sulla base dell’incolato e considerata non solo come destinataria delle utilità del fondo, ma come pluralità di soggetti titolati chiamati a gestire collettivamente il patrimonio civico secondo regole consuetudinarie per preservare il godimento dei beni stessi alle future generazioni di utenti; 2) la terra di collettivo godimento, che va riguardata come un ecosistema completo con una propria individualità, un patrimonio non solo economico, ma naturale e culturale, comprendente tutte le componenti naturali ed antropiche, dal suolo, con i connessi miglioramenti, al sottosuolo, alle acque superficiali e sotterranee e più in generale al paesaggio; 3) l’elemento teleologico, ossia lo scopo istituzionale, diverso e trascendente rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunità.
Nel Centro-Nord il patrimonio collettivo viene normalmente gestito da un ente dotato di personalità giuridica. Nell’Italia meridionale e insulare viene, invece, gestito dai comuni e si è fatto di tutto per dimenticare la sua origine. Tuttavia, oggi costituisce un’opportunità per formare una nuova società civile da responsabilizzare nella gestione sostenibile di fondamentali beni comuni. Ma occorre restituire la gestione alle collettività ricostituendo enti autonomi e separati dalle amministrazioni comunali. In base alle normative vigenti (nazionali e regionali), tali patrimoni possono essere sottratti alla gestione dei comuni e gestiti dall’A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico): un’entità organizzata, diversa e separata dal comune e appositamente costituita per la gestione separata delle terre collettive e per la loro valorizzazione e fruizione sociale. Il comitato per gestire l’A.S.B.U.C. è composto di cinque membri e dura in carica quattro anni. Esso viene eletto dalla generalità dei cittadini residenti nel comune dove è situato il bene.
Per avviare un’A.S.B.U.C. occorre costituire un comitato promotore (in media sono sufficienti cinque persone) che si faccia carico di interagire con l’amministrazione comunale e coi competenti uffici regionali al fine di trasmettere al Prefetto la richiesta di adozione del decreto per l’indizione delle elezioni comunali. Promuovendo e formando amministratori di beni comuni che non rispondano a logiche partitiche o proprie della pubblica amministrazione, ma direttamente ai cittadini che li eleggono ogni quattro anni per quella determinata finalità, forse si potrà contribuire a creare una nuova società civile. Bisognerebbe scommetterci per generare benessere, valorizzare risorse naturali e rivitalizzare capitale sociale.